di Enzo Terzi
 I periodi di grandi migrazioni, nella maggior parte dei casi e dei Paesi, non sono effetto diretto di scompensi unicamente economici. Il loro prodursi proviene da origini più complesse, identificabili nelle trasformazioni che si accompagnano quale concausa, alle trasformazioni politiche di una nazione.
I periodi di grandi migrazioni, nella maggior parte dei casi e dei Paesi, non sono effetto diretto di scompensi unicamente economici. Il loro prodursi proviene da origini più complesse, identificabili nelle trasformazioni che si accompagnano quale concausa, alle trasformazioni politiche di una nazione.
L’Italia, reduce recente dallo stravolgente evento della creazione della Unità, politicamente conclusosi nel 1861, manifesta nei decenni a seguire, tutta la fragilità di una spinta che si era rivelata per molti intellettuali il crollo di un sogno lungamente inseguito.
Le manifestazioni letterarie che accompagnarono i decenni seguenti, imposero sia ai più aristocratici personaggi come Carducci, sia a coloro, rimasti profondamente romantici ancor prima che realisti come De Amicis, una scelta ben precisa: isolarsi dagli accadimenti e restare nella torre d’avorio della alta cultura che cerca di passare indenne sopra le umane vicende fornendone interpretazione mediata ed ispirata, oppure cercare di suscitare un sentimento intimista, attingendo ai fatti comuni e popolari, mostrandone le condizioni pur esentandosi dal trarre conclusioni dichiaratamente politiche, indulgendo piuttosto sulla forza di sentimenti imperituri di epopee familiari dilaniate dalle condizioni di una povertà che non necessariamente precipitava nella misera morale ma, anzi, reagiva con la riaffermazione di sentimenti che facevano da argine a tanto sconquasso.
 In questo universo intellettuale e letterario, le figure quali Verga (e Pirandello poi) non rinunciando ad assumersi responsabilità che il mondo intellettuale non dovrebbe mai dimenticare, si assumono il compito di attingere alle condizioni umane della povera gente e di certa nascente borghesia per metterne a nudo ora l’impatto della povertà sulle miserie più profonde del vivere, ora il senso ipocrita che accompagna la crescita di nuove forme di materiale ricchezza. E ciò accadde con una immediatezza che dimostra quanto palesemente l’Unità fosse stata evento storico talora colpevolmente avulso dalla realtà culturale e sociale dei Paesi che ne avrebbero costituto l’insieme geografico.
In questo universo intellettuale e letterario, le figure quali Verga (e Pirandello poi) non rinunciando ad assumersi responsabilità che il mondo intellettuale non dovrebbe mai dimenticare, si assumono il compito di attingere alle condizioni umane della povera gente e di certa nascente borghesia per metterne a nudo ora l’impatto della povertà sulle miserie più profonde del vivere, ora il senso ipocrita che accompagna la crescita di nuove forme di materiale ricchezza. E ciò accadde con una immediatezza che dimostra quanto palesemente l’Unità fosse stata evento storico talora colpevolmente avulso dalla realtà culturale e sociale dei Paesi che ne avrebbero costituto l’insieme geografico.
Nel bel mezzo di questo disorientamento che un evento quale l’Unità non ha solo procurato – inevitabilmente peraltro – a chi non ne fosse stato attore specie nella fase conclusiva quando si intravedeva chiaramente forma e formulazione che avrebbe assunto, fanno spicco riflessioni quale questa di Verga che nel 1873, nella prefazione della prima edizione del suo romanzo “Eva”, offre una constatazione serena quanto incredibilmente premonitrice di certi processi sociali che ancora oggi sono al centro dell’attenzione.
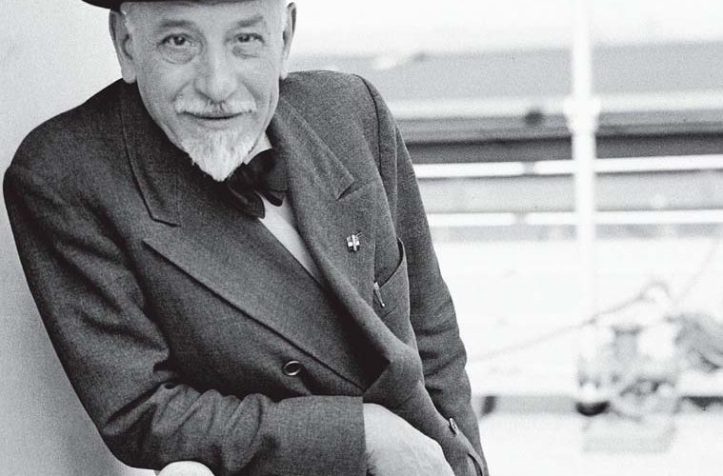 Così scriveva: “I greci innamorati ci lasciarono la statua di Venere; noi lasceremo il cancan litografato sugli scatolini da fiammiferi. Non discutiamo nemmeno sulle proporzioni; l’arte allora era una civiltà, oggi è un lusso: anzi un lusso da scioperati. La civiltà è il benessere, e in fondo ad esso, quand’è esclusivo come oggi, non troverete altro, se avete il coraggio e la buona fede di seguire la logica, che il godimento materiale. In tutta la serietà di cui siamo invasi, e nell’antipatia per tutto ciò che non è positivo — mettiamo pure l’arte scioperata — non c’è infine che la tavola e la donna. Viviamo in un’atmosfera di Banche e di Imprese industriali, e la febbre dei piaceri è la esuberanza di tal vita. Non accusate l’arte, che ha il solo torto di aver più cuore di voi, e di piangere per voi i dolori dei vostri piaceri. Non predicate la moralità, voi che ne avete soltanto per chiudere gli occhi sullo spettacolo delle miserie che create, — voi che vi meravigliate come altri possa lasciare il cuore e l’onore là dove voi non lasciate che la borsa, — voi che fate scricchiolare allegramente i vostri stivali inverniciati dove folleggiano ebbrezze amare, o gemono dolori sconosciuti, che l’arte raccoglie e che vi getta in faccia”.
Così scriveva: “I greci innamorati ci lasciarono la statua di Venere; noi lasceremo il cancan litografato sugli scatolini da fiammiferi. Non discutiamo nemmeno sulle proporzioni; l’arte allora era una civiltà, oggi è un lusso: anzi un lusso da scioperati. La civiltà è il benessere, e in fondo ad esso, quand’è esclusivo come oggi, non troverete altro, se avete il coraggio e la buona fede di seguire la logica, che il godimento materiale. In tutta la serietà di cui siamo invasi, e nell’antipatia per tutto ciò che non è positivo — mettiamo pure l’arte scioperata — non c’è infine che la tavola e la donna. Viviamo in un’atmosfera di Banche e di Imprese industriali, e la febbre dei piaceri è la esuberanza di tal vita. Non accusate l’arte, che ha il solo torto di aver più cuore di voi, e di piangere per voi i dolori dei vostri piaceri. Non predicate la moralità, voi che ne avete soltanto per chiudere gli occhi sullo spettacolo delle miserie che create, — voi che vi meravigliate come altri possa lasciare il cuore e l’onore là dove voi non lasciate che la borsa, — voi che fate scricchiolare allegramente i vostri stivali inverniciati dove folleggiano ebbrezze amare, o gemono dolori sconosciuti, che l’arte raccoglie e che vi getta in faccia”.
Nel frattempo era iniziata la lunga era della migrazione italiana che sarebbe durata fino agli anni venti del novecento, per poi riprendere, in altra forma, allorché, invece, si celebrava il grande boom del dopoguerra. Tra questi interpreti della realtà, dei sogni spesso disattesi, tra questi osservatori delle condizioni sociali, in quel periodo emergono due nomi, quello di Edmondo De Amicis e quello di Carlo Lorenzini. Il primo che ci ha regalato l’epopea del libro “Cuore” e l’altro “Le avventure di un burattino chiamato Pinocchio”. E se quest’ultimo resta forse l’unico lavoro di Lorenzini che trascenda i meri intenti pedagogici, per il primo si può parlare di un vero e proprio caposaldo della nostra letteratura.
Ma anche il De Amicis, peraltro giornalista che aveva saputo mirabilmente portarci fino ad Istanbul con i suoi reportages ad assaggiare anche mondi che ancora potevano destare meraviglia, dopo Cuore, tuttavia, anziché imboccare la via maestra del romanzo realista che avrebbe potuto fargli assumere il ruolo di intellettuale che denuncia, si ripiega prudentemente verso una meticolosa osservazione del mondo che lo circonda da una posizione di distacco che ci lascia interdetti, come se la personale delusione in quanto uomo del Risorgimento lo avesse ricondotto ad un ruolo di distaccato osservatore delle tribolazioni universali.
Così le passioni di Cuore sembrano spengersi in una narrazione che non è più in grado di coinvolgere. E’ questo il caso ad esempio del racconto “Sull’oceano” che narra del suo viaggio in America Latina e, con esso, di uno dei tanti episodi della migrazione massiccia dalle miserie italiane di tanta gente.
Non si tratta di estetica letteraria quanto della consapevolezza che lo scrittore, risentendo dell’esperienza giornalistica ma anche della propria formazione elitaria, distribuisca oramai la propria attenzione con toni che restano uniformi, sia alle bizzarie di una nuova ricca coppia borghese che a qualche caso di pellagra che distruggerà ad una povera famiglia il sogno di potersi imbracare per le Americhe: “Delle povere donne che avevano un bambino da ciascuna mano, reggevano i loro grossi fagotti coi denti; delle vecchie contadine in zoccoli, alzando la gonnella per non inciampare nelle traversine del ponte, mostravano le gambe nude e stecchite; molti erano scalzi, e portavan le scarpe appese al collo. Di tratto in tratto passavano tra quella miseria signori vestiti di spolverine eleganti, preti, signore con grandi cappelli piumati, che tenevano in mano o un cagnolino, o una cappelliera, o un fascio di romanzi francesi illustrati, dell’antica edizione Lévy. […]
 Ed era una pietà veder quelle donne scendere stentatamente per le scalette ripide, e avanzarsi tentoni per quei dormitori vasti e bassi, tra quelle innumerevoli cuccette disposte a piani come i palchi delle bigattiere, e le une, affannate, domandar conto d’un involto smarrito a un marinaio che non le capiva, le altre buttarsi a sedere dove si fosse, spossate, e come sbalordite, e molte andar e venire a caso, guardando con inquietudine tutte quelle compagne di viaggio sconosciute, inquiete come loro, confuse anch’esse da quell’affollamento e da quel disordine. […]A un tratto s’udiron delle grida furiose dall’ufficio dei passaporti e si vide accorrer gente. Si seppe poi che era un contadino, con la moglie e quattro figliuoli, che il medico aveva riconosciuti affetti di pellagra. Alle prime interrogazioni, il padre s’era rivelato matto, ed essendogli stato negato l’imbarco, aveva dato in ismanie”. Per quanto accalorato, De Amicis mantiene toni che sono lontani da una letteratura che sia anche impegno civile e che possa assurgere a monito. “Era una pietà …” vedere le donne e la famiglia affetta da pellagra si avvale unicamente del padre che “…aveva dato in ismanie”, quale sintesi dell’immensa tragedia che li aveva colpiti, arrivando alla nave dopo che la malattia li aveva uccisi due volte, nel corpo e nei sogni. Non suoni tuttavia ciò a condanna; già considerare seppur con un poco di mestiere e di condiscendenza la realtà circostante era in fondo da ammirare al momento in cui il muro tra le classi sociali si andava delineando come ancora più alto di prima, non esistendo più quelle divisioni indiscutibili che secoli di feudalesimo avevano mantenuto e trovandosi dunque nelle condizioni che anche il vicino, magari più fortunato, potesse diventare un ulteriore sconosciuto, un nuovo padrone inatteso. In questa completa mancanza di riferimenti si arrivava alle navi della speranza – in maniera spesso non tanto dissimile a quella che oggi tanta miseria umana raggiunge le nostre coste. E si partiva, nel migliore dei casi, con una lettera sbiadita dai mesi nella tasca, unico riferimento per trovare, lontano oltre ogni immaginazione, la fine di quel filo di speranza che aveva portato all’imbarco, spesso, allora come oggi talvolta, mettendo insieme la somma necessaria a forza di aiuti, prestiti, sudore e solidarietà. A questa migrazione, ai caratteri intimi e caratteriali dei singoli, al binomio un uomo-una storia, tutte apparentemente uguali e tutte intimamente diverse, De Amicis consacrerà una buona parte della sua attività di scrittore, restituendoci, comunque, l’attenzione sull’unica risorsa che l’Italia emersa dal caos dell’Unità aveva a disposizione per la propria costruzione: l’educazione e l’istruzione.
Ed era una pietà veder quelle donne scendere stentatamente per le scalette ripide, e avanzarsi tentoni per quei dormitori vasti e bassi, tra quelle innumerevoli cuccette disposte a piani come i palchi delle bigattiere, e le une, affannate, domandar conto d’un involto smarrito a un marinaio che non le capiva, le altre buttarsi a sedere dove si fosse, spossate, e come sbalordite, e molte andar e venire a caso, guardando con inquietudine tutte quelle compagne di viaggio sconosciute, inquiete come loro, confuse anch’esse da quell’affollamento e da quel disordine. […]A un tratto s’udiron delle grida furiose dall’ufficio dei passaporti e si vide accorrer gente. Si seppe poi che era un contadino, con la moglie e quattro figliuoli, che il medico aveva riconosciuti affetti di pellagra. Alle prime interrogazioni, il padre s’era rivelato matto, ed essendogli stato negato l’imbarco, aveva dato in ismanie”. Per quanto accalorato, De Amicis mantiene toni che sono lontani da una letteratura che sia anche impegno civile e che possa assurgere a monito. “Era una pietà …” vedere le donne e la famiglia affetta da pellagra si avvale unicamente del padre che “…aveva dato in ismanie”, quale sintesi dell’immensa tragedia che li aveva colpiti, arrivando alla nave dopo che la malattia li aveva uccisi due volte, nel corpo e nei sogni. Non suoni tuttavia ciò a condanna; già considerare seppur con un poco di mestiere e di condiscendenza la realtà circostante era in fondo da ammirare al momento in cui il muro tra le classi sociali si andava delineando come ancora più alto di prima, non esistendo più quelle divisioni indiscutibili che secoli di feudalesimo avevano mantenuto e trovandosi dunque nelle condizioni che anche il vicino, magari più fortunato, potesse diventare un ulteriore sconosciuto, un nuovo padrone inatteso. In questa completa mancanza di riferimenti si arrivava alle navi della speranza – in maniera spesso non tanto dissimile a quella che oggi tanta miseria umana raggiunge le nostre coste. E si partiva, nel migliore dei casi, con una lettera sbiadita dai mesi nella tasca, unico riferimento per trovare, lontano oltre ogni immaginazione, la fine di quel filo di speranza che aveva portato all’imbarco, spesso, allora come oggi talvolta, mettendo insieme la somma necessaria a forza di aiuti, prestiti, sudore e solidarietà. A questa migrazione, ai caratteri intimi e caratteriali dei singoli, al binomio un uomo-una storia, tutte apparentemente uguali e tutte intimamente diverse, De Amicis consacrerà una buona parte della sua attività di scrittore, restituendoci, comunque, l’attenzione sull’unica risorsa che l’Italia emersa dal caos dell’Unità aveva a disposizione per la propria costruzione: l’educazione e l’istruzione.
Su questi due principi si costruirà tutta la teoria illuminata degli intellettuali nuovi e sopravvissuti alle delusioni post-garbaldine, da De Sanctis a Cattaneo, da Capuana, a Verga, a De Roberto ed altri ancora, interpreti tutti di quel realismo letterario che troverà il coraggio di diventare non solo notarile osservazione spesso anche indulgente della realtà,ma manifesto di denuncia che passò sotto il nome di verismo. De Amicis, che pure aveva tutte le informazioni in mano per poter appartenere a questo movimento, pur nella capacità meticolosa di mettere a nudo miserie e tragedie, fa scaturire il dramma non dalla dura consapevolezza della condizione sociale del paese ma utilizza la stessa, forse ultimo tra i romantici, per far emergere il dramma strappalacrime che possa risvegliare sensi materni, sopiti amor di Patria, in parte cieco ed in parte inconsapevole di quanto in realtà sta rappresentando.
 Sarà soltanto alla fine del secolo, quando inizierà ad abbracciare le idee socialiste che la sua prosa si farà più attenta, meno descrittiva e più allusiva: povertà e misera non saranno più destino inoppugnabile della condizione umana ma conseguenza ed effetto di condizioni storiche da denunciare. E forse proprio conoscendo gli scritti del De Amicis socialista, si riesce a dare un senso anche storico e morale ai suoi testi degli anni ’80 che mantengono in quel quieto scorrere della disperazione, una sorta di distacco che non riesce a colmare.
Sarà soltanto alla fine del secolo, quando inizierà ad abbracciare le idee socialiste che la sua prosa si farà più attenta, meno descrittiva e più allusiva: povertà e misera non saranno più destino inoppugnabile della condizione umana ma conseguenza ed effetto di condizioni storiche da denunciare. E forse proprio conoscendo gli scritti del De Amicis socialista, si riesce a dare un senso anche storico e morale ai suoi testi degli anni ’80 che mantengono in quel quieto scorrere della disperazione, una sorta di distacco che non riesce a colmare.
De Amicis affronta il suo viaggio dal ponte superiore, fianco a fianco della borghesia spesso agiata che osservava dall’alto le miserie così come da casa le osservava da lontano. Ma la nave, nel suo microcosmo, si fa portatrice della realtà che a poco sarebbe apparsa. Gli argentini se ne stavano in disparte e sui loro sentimenti nei nostri confronti, lo scrittore inizia, nel corso della navigazione, a darci qualche accenno di dubbio: “Quanto all’Italia, non riuscii a scoprire, sotto la necessaria cortesia della frase, il loro sentimento vero. Si compiacevano della nostra immigrazione, come d’un concorso di ottimi lavoratori, e accennando gli emigranti, dicevano: — Tutto questo è tant’oro per noi. — Portateci pure tutta l’Italia, pur che lasciate a casa la Monarchia. — E si capiva che a loro, come ai rivoluzionari francesi del secolo scorso, una povera creatura umana soggetta alla Monarchia pareva meritevole della più sincera commiserazione; e che ci dovevano considerare, noi europei, come una specie d’uomini nati vecchi, strascicantisi in mezzo agli avanzi tristi d’un mondo morto, e anche un po’ affamati per professione.
Di sotto a questi sentimenti, lampeggiava un orgoglio nazionale vivissimo; l’orgoglio d’un piccolo popolo, che ha vinto la grande Spagna, umiliata l’Inghilterra, e allargato i confini del mondo civile, spazzando la barbarie da un paese immenso, per darvi ospizio e vita a gente d’ogni lingua e d’ogni razza”. Ricompare la delusione per quell’Italia partorita per come non avrebbe dovuto, rachitica nella sua crescita per i vecchi privilegi che anziché scomparire si adattavano a corpi diversi, a forme diverse di potere. E’ la delusione dell’uomo che aveva creduto nel Risorgimento, l’intellettuale che scopre di aver mal riposto i propri ideali.
Ai disgraziati forse poco sarebbe cambiato, solo la lingua in cui sarebbero stati urlati gli ordini e i divieti. Quelli dei ponti inferiori tuttavia si distanziano dal De Amicis ogni miglio percorso sempre di più, fino a quando, in prossimità oramai della costa vorrebbe lo ascoltiamo rimpiangere di non aver rivolto parola ai ricchi argentini presenti lasciando senza voce una sorta di preghiera non consegnata che suona tuttavia come quella di uno zio che si stia liberando del figlio del fratello morto, per anni accudito senza niente avere in cambio: “Voi accoglierete bene questa gente, non è vero? Sono volontari valorosi che vanno a ingrossare l’esercito col quale voi conquistate un mondo. Son buoni, credetelo; sono operosi, lo vedrete, e sobrii, e pazienti, che non emigrano per arricchire, ma per trovar da mangiare ai loro figliuoli, e che s’affezioneranno facilmente alla terra che darà loro da vivere. Sono poveri, ma non per non aver lavorato; sono incolti, ma non per colpa loro, e orgogliosi quando si tocca il loro paese, ma perché hanno la coscienza confusa d’una grandezza e d’una gloria antica; e qualche volta sono violenti; ma voi pure, nipoti dei conquistatori del Messico e del Perù, siete violenti.
E lasciate che amino ancora e vantino da lontano la loro patria, perché se fossero capaci di rinnegar la propria, non sarebbero capaci d’amar la vostra. Proteggeteli dai trafficanti disonesti, rendete loro giustizia quando la chiedono, e non fate sentir loro, povera gente, che sono intrusi e tollerati in mezzo a voi.
Trattateli con bontà e con amorevolezza. Ve ne saremo tanto grati! Sono nostro sangue, li amiamo, siete una razza generosa, ve li raccomandiamo con tutta l’anima nostra”! E’ evidente, ahimè il senso di non appartenenza a tale classe sociale ed ai dolori che con sé porta, capaci oramai unicamente di destare un moto di compassione più dovuto a doveri morali che non a quei sentimenti che avevano animato le pagine di Cuore. La realtà avrebbe comunque spianato poi ogni commento ed ogni appello.
Duro sarebbe stato per tutti, in molti avrebbero sofferti gli stenti che avevano creduto di lasciare alle spalle, altri, pochi, avrebbero fatto fortuna, altri ancora, sarebbero scomparsi in quel limbo che fino a pochi anni fa si sarebbe potuto definire “normalità”, sarebbero passati accanto alla storia senza che la stessa li abbia degnati di uno sguardo, ma se la sarebbero cavata con un piccolo lavoro, una piccola famiglia, piccole gioie e piccoli dolori e già tanto sarebbe stato. La grande epopea della migrazione italiana almeno trovò in De Amicis un portavoce, discutibile forse per quel suo distaccato fare notarile che ce lo rende a tratti anche irriconoscibile. Niente in realtà sarà diverso sull’altra sponda dell’Atlantico: la fortuna andrà sudata, la sorte sfidata, l’accoglienza, salvo quei rari casi che non fanno storia ma solo colore, sarà quella vissuta da ogni emigrato di ogni paese, di ogni colore, di ogni epoca e l’integrazione il solito cammino irto di quelle differenze che ci eravamo illusi di lasciare in patria: denaro e cultura gli unici salvagente e certo il primo più della seconda.
A nulla servono né le conquiste né le Unità, né i risorgimenti che passano come periodiche rivoluzioni lungo la storia, come valvole di sfogo, come legge dell’alternanza. In fondo ancora oggi ci ritroviamo talvolta a dare ragione al principe di Francalanza che Federico De Roberto volle protagonista ne “I viceré” (1894): “ La storia è una monotona ripetizione, gli uomini sono stati, sono e saranno sempre gli stessi. Le condizioni esteriori mutano; certo tra la Sicilia prima del Sessanta, ancora quella feudale e questa d’oggi, pare ci sia un abisso; ma la differenza è tutta esteriore. Il primo eletto col suffragio quasi universale non è né un popolano né un borghese né un democratico: sono io perché io mi chiamo principe di Francalanza”.
twitter@PrimadiTuttoItaliani

